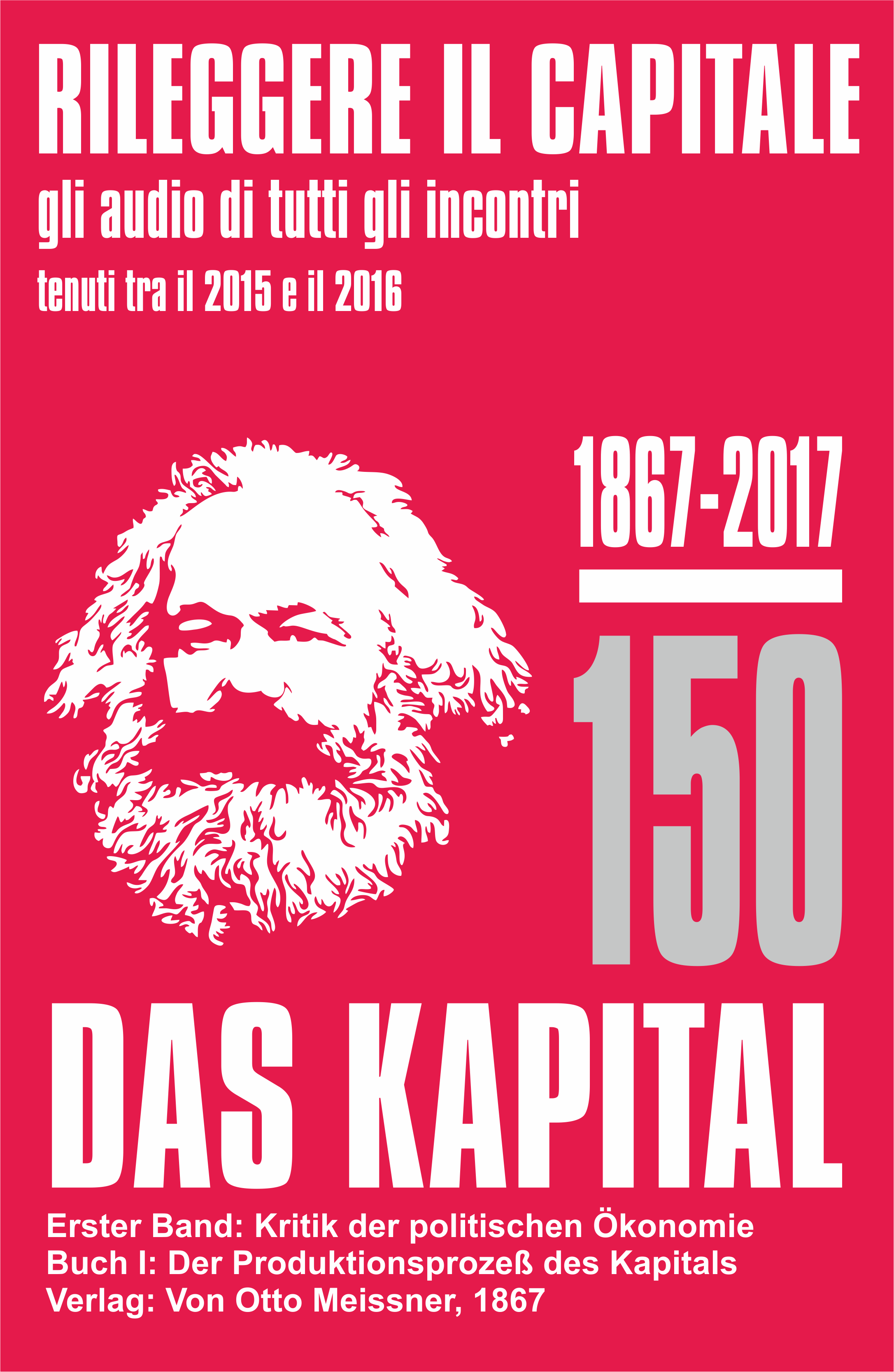Antiper | Recensione a “L’epoca delle passioni tristi” di Miguel Benasayag e Gérard Schmit

Il libro di Miguel Benasayag e Gérard Schmit L’epoca delle passioni tristi si propone di indagare il crescente disagio nelle società occidentali, specialmente tra gli adolescenti, partendo dalla constatazione che mentre nel passato i ragazzi più problematici provenivano soprattutto dalla periferia e dai quartieri più poveri, oggi il disagio tende a generalizzarsi a tutti i quartieri e quindi, dovremmo pensare, a tutte le fasce sociali.
Gli autori partono dalla constatazione che si è ormai consumato il passaggio da un futuro-promessa ad un futuro-minaccia e non solo dal punto di vista economico.
L’Occidente aveva fondato i suoi sogni sulla convinzione che la storia dell’umanità fosse inevitabilmente storia di progresso; se in precedenza il processo storico permetteva di guardare al futuro come ad una promessa di sempre maggior benessere, di sempre maggiore felicità, oggi questa fiducia non esiste più: è avvenuta una vera e propria rottura che ha ucciso la speranza “storicista” di un futuro migliore. O forse sarebbe meglio dire così: è venuta meno, non tanto la convinzione che il futuro sia sempre necessariamente migliore, ma piuttosto che un futuro migliore sia anche soltanto possibile.
Una volta introiettata l’insuperabilità del mondo esistente non abbiamo neppure la speranza di poterlo cambiare e dunque non facciamo nulla per cambiarlo. Anche questo è un effetto deleterio della rimozione della speranza (di un certo cambiamento) che portava con sé il desiderio (di tale cambiamento) e infine l’azione (per tale cambiamento). Una cosa che Umberto Galimberti si ostina a non capire, ma che invece Ernst Bloch capiva benissimo. Non è dunque paradossale, come vedremo, che neppure questo libro (che su questo punto si situa più in prossimità di Galimberti che di Bloch), riesca a sfuggire a tale deriva (non spero più nel cambiamento e dunque non faccio niente per realizzarlo finendo dunque per renderlo ancora più improbabile).
Freud pensava che “in mancanza della felicità, gli uomini si accontentano di evitare l’infelicità”. Ma forse oggi anche “evitare l’infelicità” è diventato un compito troppo arduo. Siamo in un’epoca dominata dalle “passioni tristi”, così come le chiamava Spinoza.
Impotenza e disgregazionesono i due tratti caratteristici del nostro modo di sentire.
Da un sentimento di onnipotenza siamo passati a un sentimento di impotenza e gli uomini si percepiscono come totalmente in balìa delle spinte irrazionali della storia. Anche il rapporto con le macchine è un rapporto di subalternità e non di controllo (come Marx aveva mostrato molto prima e molto più efficacemente di Heidegger); ma di questo, probabilmente, neppure si rendono conto le centinaia di milioni di persone che controllano ininterrottamente Facebook, la posta elettronica, Whatsup…
Per proteggerci dall’angoscia che deriva dal senso di impotenza tendiamo a rinchiuderci in forme autistiche (come i videogames che tra l’altro influiscono sulla capacità di attenzione durante le lezioni) e nichilistiche (battaglie contro il nulla, percorsi che non conducono da nessuna parte fatti “tanto per fare qualcosa”).
La crisi globale è anche crisi del “principio di autorità” (ma qui forse sarebbe stato meglio distinguere tra autorità e autorevolezza). Entrano in crisi i principi che permettevano all’adulto di “educare” e “proteggere” il giovane, anche se, si dovrebbe aggiungere, molto spesso sono (stati) proprio gli adulti ad essere fonte del disagio giovanile, sia in senso generale per la deriva della società che consegnano loro, sia in senso specifico per le azioni che compiono nei loro confronti.
La relazione con l’adulto diventa simmetrica e i due termini della relazione stabiliscono reciprocamente un rapporto di tipo contrattuale. Educatori e genitori si sentono tenuti a giustificare le proprie scelte nei confronti del giovane, che può accettare o meno ciò che gli viene proposto. Quello che scrivono Benasayag e Schmit è sicuramente vero: e d’altra parte, come si manteneva, ammesso che vi si fosse, la precedente asimmetria? Fondamentalmente in due modi: il primo modo – coercitivo – attraverso la violenza paterna e più in generale attraverso un rapporto di tipo patriarcale; il secondo – apparentemente “spontaneo” – attraverso il senso comune ovvero attraverso quella che Platone chiama, nel IV libro della Repubblica, la tradizione (che dovrebbe suggerire i nostri comportamenti verso gli adulti e i vecchi indipendentemente dalle norme di legge vere e proprie).
Su cosa si è basata da sempre l’autorevolezza nel principio di autorità? Sull’anteriorità, sul semplice fatto che essere più vecchi significa, si presume, essere portatori di maggiore saggezza.
“La vecchiaia non è solo un destino biologico, ma anche storico-culturale. Quando il tempo era ciclico e ogni anno il ritmo delle stagioni ripeteva se stesso, chi aveva visto di più sapeva di più. Per questo “conoscere è ricordare”, come annota Platone nel Menone, e il vecchio, nell’accumulo del suo ricordo, era ricco di conoscenza. Oggi con la concezione progressiva del tempo, non più ciclico nella sua ripetizione, ma freccia scagliata in un futuro senza meta, la vecchiaia non è più deposito di sapere, ma ritardo, inadeguatezza, ansia per le novità che non si riescono più a controllare nella loro successione rapida e assillante” [1]
Ma questo oggi non è più vero. Chi arriva dopo sembra essere più avanti in un mondo in cui la conoscenza appare cumulativa. Grazie alle tecnologie elettroniche e informatiche i giovani sembrano essere “più avanti” dei loro genitori che si presentano invece “in ritardo” (e forse in ritardo incolmabile) rispetto ai ritmi della società contemporanea.
Interessante evidenziare come alla crisi del principio di autorità non corrisponda una messa in discussione dell’autoritarismo: che anzi trova nuove strade. In una società in cui i meccanismi di autorità sono indeboliti, lungi dall’inaugurare un’epoca di libertà, entra in un periodo di arbitrarietà e di confusione. Si potrebbe anche dire così: i giovani non riconoscono più l’autorità dei genitori o degli educatori, e allo stesso tempo non esprimono nessuna contestazione all’autorità costituita e ai suoi modelli (come “pare” abbiano fatto i loro predecessori “sessantottini” o “settantini”): ricchi, potenti, violenti, veline… possono dunque essere veri e propri modelli di riferimento. Se mio padre è stato licenziato è solo perché è un fallito: io non devo essere come lui.
All’origine del disagio c’è, secondo gli autori, il funzionamento di una società che con i suoi modelli, i suoi ritmi di vita, la sua serializzazione, il suo costringere le persone ad essere sempre efficienti, crea uno iato tra ciò che siamo e ciò che si vorrebbe che fossimo.
Ma se il problema sta soprattutto nel funzionamento della società – aggiungiamo noi, capitalistica – allora diventa del tutto inadeguato che gli psicoterapeuti, o altre figure simili, si limitino ad intervenire sulle semplici manifestazioni dei problemi: bisogna piuttosto risalire alle loro origini.
Questo concetto viene spiegato efficacemente attraverso due esempi: quello che possiamo chiamare del “dermatologo della Patagonia” e quello che chiameremo del “bambino dal nome straniero”.
Nel primo caso il punto di partenza è il fatto che in Patagonia, a causa del buco dell’ozono, molte persone sono afflitte da malattie della pelle. Il dermatologo cura queste malattie con la pomata. Nuovi pazienti, altra pomata. Ma così il problema non si risolve: i malati continuano ad ammalarsi e la pomata finisce per essere solo un palliativo. E’ la metafora dei limiti di una psichiatria che non interviene sulle cause del disagio e finisce per diventare semplice palliativo, spesso inefficace, dei suoi effetti.
Nel secondo esempio c’è un bambino di origini asiatiche che viene adottato da una coppia di genitori francesi i quali temono che, proprio a causa del nome straniero, il bambino possa essere oggetto di insulti razzisti. Pensano allora di affrontare il problema cambiando nome al bambino. Ma cambiare il nome ai bambini adottati è davvero una soluzione al problema del razzismo? E noi aggiungeremmo: è davvero possibile “risolvere” il problema del razzismo in una società che spinge ognuno di noi a concepire la differenza non come ricchezza, ma come separazione e anzi ad utilizzarla per metterci in competizione tutti contro tutti?
Benasayag e Schmit sembrano dunque cogliere correttamente il limite della propria disciplina, ma non sembrano cogliere la soluzione (che comincia, a nostro avviso, proprio dal superamento della logica della “separazione disciplinare” e dalla comprensione che la dimensione psichica individuale è sempre indissolubilmente legata alla dimensione storico-sociale della propria esistenza). Di questo passaggio gli autori sembrano essere consapevoli ma, ciò nonostante, si limitano ad invocare una riforma interna della “psicanalisi” e ad auspicare la nascita di una “clinica della molteplicità” che permetta di considerare le persone come espressione di una pluralità variegata di cose.
In questo modo lo sguardo può allargarsi e un ragazzo o una ragazza persona non sono più solo figli dei propri genitori, ma sono anche studenti, musicisti, scrittori… Da questo approccio emerge chiaramente anche una critica al modello psicanalitico freudiano.
La “clinica della molteplicità” deve superare la classificazione delle persone in “normali” e “patologiche” e aiutare i pazienti a convivere con i propri disagi che sono più ampi della persona (perché hanno a che fare anche con il contesto sociale, economico, culturale…) e dunque sono insuperabili nel loro complesso.
Ed è qui che la “clinica della molteplicità” diventa “clinica della rassegnazione”, quando suggerisce che dalle patologie non si guarisce perché in realtà non sono patologie, ma semplici condizioni di vita alle quali ci si deve abituare (o, per meglio dire, rassegnare).
Bisogna cercare di vivere “passioni gioiose” (come avrebbe detto Spinoza), trovare qualcosa che amiamo fare e farlo senza pretendere di cambiare il mondo o, ancora più semplicemente, la propria condizione.
Sei un folle con manie omicide o suicide? Non importa, impara a suonare la chitarra e goditi questo nuovo hobby; non ti curerà (perché non ci può essere cura, dal momento che non c’è malattia), ma ti farà stare meglio. E a questo punto è lecito domandarsi quale sia la differenza con le varie soluzioni “psicotrope”…
Il ragionamento che sembra essere sotteso è il seguente: molti dei tuoi problemi vengono dalla tua condizione. Dunque, o sei in grado di cambiarla oppure non puoi far altro che conviverci. E comunque per una persona che riesce a cambiare la propria condizione ce ne saranno sempre milioni che non ci riescono. A questo punto, se si vive la propria condizione in modo negativo si finisce per cadere nell’infelicità; se invece si riesce a trovare qualcosa che ci faccia appassionare gioiosamente, questa infelicità può essere temperata, ridotta. Si può essere felici anche vivendo una condizione sociale, familiare, psichica… negativa. Una classica soluzione intimistica: il mondo fa schifo, ma io posso comunque essere felice e gioioso nel mio mondo.
In ogni caso, una soluzione straordinariamente somigliante alla pomata del dermatologo della Patagonia; per l’ennesima volta, infatti, il problema viene da fuori, ma la soluzione viene da dentro (e allora non si capisce più la critica iniziale al classico approccio psico-terapeutico).
Date queste premesse non è affatto paradossale che il libro non esorti le persone ad andare a cogliere le radici profonde dei problemi, che non sottolinei la necessità di un cambiamento politico globale, che non indichi nel capitalismo la causa fondamentale del disagio crescente (ed anzi, la parola stessa capitalismo è sostanzialmente bandita dal libro e sostituita con altre parole meno “politicizzate” come “utilitarismo” o “economicismo”).
Ma se in tutto il libro gli autori scelgono accuratamente di non usare mai la parola “capitalismo” o “profitto”, ma sempre e solo la parola “economico”, non è per caso.
Questa gigantesca “rimozione” concettuale e politico-culturale (che in un uomo con la biografia di Miguel Benasayag [2] segnala probabilmente anche una rimozione psicologica) la dice lunga sulla possibilità che gli psico-terapeuti, con tutte le loro buone intenzioni, possono avere di concorrere ad inquadrare in modo efficacie i problemi generati dalla società ultra-capitalistica: nessuna.
Non hanno – o non vogliono avere – neppure gli strumenti per leggere realisticamente il mondo che pretendono di affrontare. E questo è probabilmente il limite maggiore di un libro che ha comunque il pregio di proporre alcuni elementi di riflessione sul mondo in cui abitiamo.
Note
[1] Umberto Galimberti, Quando essere vecchi significava saggezza, Repubblica, 29 febbraio 2008
[2] Benasayag fu guerrillero dell’ERP, l’organizzazione comunista rivoluzionaria, duramente colpita, dalla dittatura militare argentina del 1976-83 che fece 30.000 desaparacidos. Arrestato e torturato, come la moglie, fu poi rilasciato ed espulso verso la Francia.